A casa nostra | di Antonio Rossi
A casa nostra | di Antonio Rossi
Sport 20/04/2021
So di aver rovinato tanti atleti, forse più di quanti ne sono riuscito ad ispirare. Sono sempre stato convinto di non avere un gran talento fisico, e per questo pensavo che l’unico modo che avessi per emergere fosse quello di lavorare più degli altri. Almeno il 15% in più. Non era un modo di dire, non una forma mentis, era proprio un calcolo matematico. Dal 15% in su.

Quando ho vinto il mio primo titolo italiano facevo ancora il liceo e mi allenavo con spensieratezza. Pur alzandomi presto la mattina, per fare una seduta prima di andare a scuola, c’erano ancora momenti della mia vita non dedicati interamente allo sport.
Poi ho capito che dovevo andare oltre.
Andare oltre non significa soltanto ore in più di fatica. Significa anche capire che il riposo è importante quanto l’allenamento, che se facevi tardi la mattina ne risentiva la qualità della tua prestazione, che l’alimentazione conta: tutte cose che ho imparato essere importanti, e che prima vedevo con un occhio diverso.
Il K2 500 metri, alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha perso l’oro per 32 millesimi.
Se non hai la certezza di aver fatto tutto, di essere arrivato proprio al limite delle tue umane possibilità, quei 32 millesimi ti peseranno moltissimo.
Quindi ho vissuto di conseguenza.
Ho rovinato tanti atleti perché ho messo l’asticella molto in alto, come nessuno aveva fatto prima. E quando, grazie ai risultati, sono diventato un punto di riferimento per gli altri, all’improvviso tutti gli allenatori volevano imporre ai propri ragazzi la mia stessa routine.
Nei miei allenamenti inserivo 10 km di nuoto.
Secchi, una volta a settimana.
Ogni mercoledì mattina alle 8 in punto.
Ci mettevo una vita a farli.
Che poi non servivano a un cazzo, arrivavo alla fine che non sapevo nemmeno dov’ero. Ma di testa mi facevano star bene.
Mi davano la soddisfazione fisica e mentale di sapere che non avrei proprio potuto fare di più, e questo sbloccava quello che avevo dentro.

Perché dentro, prima di tutto, devi avere l’equilibrio giusto, quello tra tecnica e forza, e per farlo bilanciare perfettamente serve un lavoro maniacale.
Sulla canoa ci sono infinite variabili: basta un singolo grado di differenza nell’entrata acqua oppure nell’appoggiare i piedi e tutto cambia. Alcune canoe sono veloci e sensibili, saltano al minimo errore, altre invece sono più mansuete ma anche molto meno aggressive.
La mia era una pagaiata di forza, anche se non ero il più forte in palestra.
Ma sul passo-gara non mi batteva nessuno.
Oggi la tecnologia aiuta moltissimo, il percorso lo puoi rivivere anche dalla tua camera d’albergo, puoi studiare gli avversari, studiare le barche.
Ora ci sono le app, noi avevamo le tabelle stampate da portarci a bordo canoa.
Quando sono arrivati i primi cardiofrequenzimetri non avevano molta memoria e non potevi in nessun modo interfacciarli con il computer. Allora, per studiare il mio battito, utilizzavo la carta millimetrata e facevo un puntino sul foglio ogni 5 secondi.
Ogni 5 secondi per un allenamento lungo un’ora e mezza.
Facevo un grafico al giorno per comparare gli allenamenti della settimana.
Poi li mettevo insieme e li mandavo via fax al mio allenatore.
Sembra incredibile a pensarci adesso, ma sono cose che non ti pesano, se hai grandi progetti. Non puoi intraprendere un viaggio simile se non ti piace fare fatica, tanto fisica quanto mentale, è un tipo di passione che conta tanto.
Il mio Mondo era una continua scoperta, perché era più grande e difficile da esplorare di quanto non sia oggi. Aspettavi i grandi eventi con la curiosità di vedere come stavano gli altri, che cosa avrebbero fatto, come alla première di un grande film.
Una volta c’erano le diverse “scuole” e filosofie di pensiero: quella ungherese, quella russa, quella tedesca. C’era molta riservatezza sugli allenamenti e non si voleva condividere nulla, come se dare un pezzetto del tuo sapere agli altri te ne avrebbe privato per sempre. Io ero una mosca bianca, amavo viaggiare, andavo in Florida con i norvegesi oppure con gli svizzeri, solo per conoscere nuove tecnologie e provare a diventare un atleta migliore.
Un campione deve essere sempre in costante evoluzione.
E forse si nasconde proprio lì la grandezza di quello che ho saputo costruire, che è durato lo spazio di 5 Olimpiadi, tutte importanti e tutte diverse.
Vent’anni al più alto livello possibile, vissuti con il fuoco di chi non si è sentivo mai abbastanza ed era sempre pronto a guadagnarsi una nuova fetta di gloria.
Cinque edizioni sono quasi una vita intera, nella quale ho attraversato tutto quello che c’era da attraversare, passando dall’incoscienza di Barcellona 1992 alla completa maturazione di Pechino 2008.
Ricordare i Giochi, i miei Giochi, significa accompagnarmi nel racconto del ragazzo che ero e dell’uomo che sono diventato, non senza pagarne il prezzo a sua maestà la fatica.
La bellezza dello sport si nasconde negli incisi di una narrativa pura, quella della grande festa che unisce i popoli e che celebra i loro sogni identitari. In Spagna ho avuto il privilegio di vivere l’ultima Olimpiade veramente “aperta”, veramente inclusiva, in cui esserci era il significato stesso dell’esperienza intera.
O quantomeno è così che l’ho vissuta io, sulla mia pelle, portando a casa un bronzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere sull’aereo di ritorno.
Già quattro anni più tardi, ad Atlanta, tutto era cambiato drasticamente.
Sentivo, anzi sapevo, di avere delle responsabilità nei confronti di molte persone, a partire dalla mia Federazione. Ero il campione del Mondo uscente, e in coppia con Daniele Scarpa non perdevamo un gara da più di un anno e mezzo. Lo dico forse con la docile arroganza di chi semplicemente sa quanto vale rispetto agli altri, ma la vittoria non era in discussione. La mia sola preoccupazione era che qualcosa di meccanico potesse rompersi.
Un guasto alla pagaia, il poggiapiedi che si spezza.
Solo quello.
E non lo temevo per me.
Mi spaventava l’idea che un inconveniente potesse privare il mio compagno della gioia di una medaglia, tale era il mio senso del dovere verso chi aveva costruito qualcosa di importante insieme a me.
Per fortuna, non si ruppe niente, e il resto è storia.
La verità è che ogni ricordo legato ai Giochi ha una vita propria, e come un fedele compagno di equipaggio passeggia al mio fianco, ognuno con la propria pagaia consumata, diventando sempre più trasparente agli occhi degli estranei, man mano che l’acqua scorre sotto ai ponti. Quello che è stato il mio presente, oggi è solo un passato, ma può dare forma al futuro di tanti.
Tutto si cristallizza e assume un’immagine assoluta, che si trasforma quasi in un pezzo di storia, reso sempre più uguale a se stesso dalla lontananza nel tempo.
Dall’emozione di essere portabandiera alla delusione di Atene 2004, quando io e Beniamino abbiamo dovuto sentirci dire che forse era meglio fingere un guasto piuttosto che accettare la mediocrità e il tritacarne della stampa.
Non fingemmo un bel niente, e con un rigurgito d’orgoglio vincemmo l’argento, la mia quinta ed ultima medaglia olimpica.
Perché dentro vent’anni di fatica e di gloria c’è tragedia e commedia in egual misura, ed è impossibile raggruppare tutto sotto l’etichetta di un solo genere teatrale.
Eppure, se dovessi scegliere una memoria per riassumere il significato dei Giochi, penso che sarebbe Pechino 2008. L’imbarcazione era il K4, e avrei dovuto gareggiare insieme a ragazzi di una generazione diversa dalla mia.
Io avevo 40 anni e il più giovane invece 23.
Siamo andati in California, tre anni prima dell’evento, per allenarci da soli, unicamente con l’obiettivo di qualificare una barca in cui nessuno aveva voglia di credere. Fallimmo la qualifica molte volte, prima di strappare il pass agli Europei, l’ultima gara in cui era possibile farlo.
Poi, in Cina, siamo finiti quarti, giusto ai piedi del podio, l’unica edizione in cui non ho vinto nulla.
Ma se penso ai Giochi, io penso ancora a quel viaggio e a quello che mi ha lasciato dentro, facendomi incontrare di nuovo il bambino che ero stato e che credevo non avrei incontrato più.
Un bambino nato a Lecco, un luogo in cui le montagne si tuffano a strapiombo nell’acqua. Un giorno sono uscito in barca e mi sono innamorato del lago.
Cominciai a passare tutto il giorno alla Canottieri, arrivavo la mattina in bicicletta e andavo via la sera. Era la mia versione della libertà e il ricordo di quelle giornate è pieno di spensieratezza.
Le medaglie contano.
Soprattutto per farsi ascoltare.
Ma dopo è quello che dici a fare la differenza, e le idee hanno radici molto più profonde dei successi che hanno contribuito a generare.
A trent’anni da Barcellona ‘92, l’olimpismo, per me, è diventato qualcosa di diverso, un progetto enorme che porterà i Cinque Cerchi all’ombra delle montagne che sento mie, visto che da piccolo passavo sempre i tre mesi estivi in Valtellina.
Venivo su con lo spirito di un bambino in gita, ammirato dalla maestosità de quei luoghi, che ora sono stati scelti per ospitare l’evento più importante in assoluto.
Per la candidatura olimpica di Milano – Cortina 2026 ero più nervoso di quanto fossi mai stato prima di una gara qualsiasi, perché dietro i documenti e i progetti c’erano la mia terra e il mio Paese. Un Paese che ha dovuto prima di tutto dialogare e trovare punti di contatto comuni, per mettere a terra una visione capace di valorizzare realtà diverse, che si riflettono tutte nei valori olimpici.
È stato difficile quanto e più di un quadriennio passato per intero a pagaiare, senza la garanzia di un posto al sole, in una rincorsa all’ultimo minuto che si concretizzava sempre in qualcosa da smontare e ricostruire.
Se penso al mio percorso, alle Cinque Olimpiadi che diventeranno Sei, e alla prossima che forse peserà quanto tutte le altre messe insieme, mi sembra di vivere il privilegio di portare la mia storia personale nel futuro degli altri.
Portare i Giochi Olimpici a Livigno è un’idea ambiziosa.
E vorrei che non interessasse solo agli sportivi, che ogni inverno ne riempiono i pendii, attratti dalla grande offerta e dal DNA giovane e progressista della città.
Ma vorrei che diventasse un fenomeno culturale, che unisce classi sociali e persone diverse, nella scoperta di un’esperienza che non ha eguali per potenza e intensità.
Resteranno gli impianti e le migliorie strutturali, questo è certo, che anche in località di assoluta avanguardia tecnologica e turistica come Livigno potranno legare per sempre i Giochi e il loro impatto culturale al ricordo di un evento storica.
Ma vorrei anche che ritornasse lo stupore dei tempi andati, per la meraviglia dello sport che si realizza nella sua forma più alta, sotto ai nostri occhi e sotto a quelli delle montagne valtellinesi.
E infatti di tutte le reazioni che ho potuto vedere, ascoltare, leggere, quella che più di tutte mi ha emozionato è stata quella di mio figlio, che con candore mi ha chiesto: “Ma quindi faranno davvero le Olimpiadi a Milano e in Valtellina?”.
Nelle sue parole ho visto l’emozione dei miei giorni alla Canottieri Lecco, della bandiera di Pechino, della carta millimetrata e delle Olimpiadi del 2026, tutte riunite dentro ad un unico pensiero bellissimo.
E ho risposto che: “sì, è proprio vero, le faremo qui.”
ANTONIO ROSSI / CONTRIBUTOR
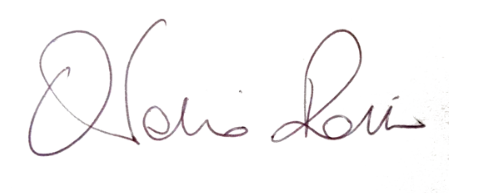


.jpg)
.jpg)

0 Commenti