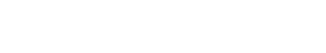Quanto pesa un carezza.
Quanto pesa un bacio.
Quanto pesa un “bravo”.
La montagna è fatta di racconti e dell’eco dei suoi venti, che nessun quadro e nessun film potranno mai riassumere in qualcosa che entra in una tasca dei blue jeans.
Le valli, i funghi e le rocce.
Le scarpe nuove messe ai piedi, quelle da corsa, che mio padre mi regalò e mi allacciò per la prima ed ultima volta, in modo che potessi seguirlo sul sentiero, in mezzo ai boschi di aghifoglie.

Il padre è sempre il primo a muovere qualcosa.
Ti pizzica le corde dell’anima, ti indirizza, ti trasmette un pensiero che è anche suo, che è unicamente suo, e che poi diventa vostro, a prescindere dalle voglie che hai.
È come un seme, che viene sotterrato dentro, e che a seconda di quanto te ne saprai, oppure vorrai, prender cura diventerà un rampicante in fiore o un’erbaccia, impossibile da estirpare.
Ero un bambino curioso, pieno di interessi diversi, che come una calamita finivano col gravitare tutti intorno alla montagna, pur facendolo ognuno per conto proprio.
Dalla botanica all’astrologia, dalla micologia allo studio della fauna: adoravo vivere come se la natura fosse maestra e i sentieri fossero classi, con la testa persa nel cielo, e i passi ben distesi.
Prima ancora di iniziare a pensare, prima di iniziare a sognare, quando tutto era ancora nascosto dalla brina del mattino, la montagna era già la mia passione più grande, ed era stato quel gran racconta-storie di mio padre a mettermela in petto.
Che poi, io non l’ho mai chiamato papà, ma sempre con il nome di battesimo, è stato così all’inizio ed è così anche ora.
Nessuno è profeta in patria, neppure chi è talmente legato alla propria terra da essere la patria stessa, e allora quando ho capito di avere spirito e voglia di arrivare, il mio sguardo di ammirazione si è posato subito sui miti più lontani.
I miti che non puoi toccare, quelli distanti, che in quanto tali non potranno mai cadere, perché ciò che vedi, di loro, è soltanto la copia bella, mandata in stampa, puntuale, senza errori di battitura.
All’inizio non ero per nulla portato per lo sport.
Però, quando il mio fisico ha cominciato a diventare un po’ più maturo, ho capito che la mia predisposizione per la corsa in salita era lì. Era un talento dentro di me che non avevo assolutamente allenato ma era li da raccogliere.
Ed è sbocciato improvvisamente.
Dalla Valtellina al resto del Pianeta, dalle passeggiate ai record mondiali, sono partito, con dentro un pezzo di casa e un pezzo di mio padre, alla scoperta di quali fossero i limiti miei e quelli di tutti gli altri.
Ho cominciato a correre, a correre in montagna, bruciando dislivelli e appianando colline, in un’epoca che, pur essendo distante solo una trentina d’anni, rappresenta l’archeologia della disciplina.
Come i dinosauri, in attesa di un asteroide che fracassa sulla terra, abbiamo “inventato” uno sport, lo abbiamo trasformato, lo abbiamo cambiato, animati dal continuo dialogo con gli elementi e dalla poesia senza tempo di una corsa senza traguardo.
Io volevo solo correre.
E quindi correvo sempre.
Riempiendo diari su diari, scrivendo fitto pagine di appunti e di riflessioni a metà strada tra il flusso di coscienza e l’analisi tecnica, tra la preghiera e il metodo scientifico.
Un po’ Freud e un po’ Dorando Pietri, riportavo su carta ogni dettaglio di ogni gara; dal grande al piccolo, dall’evidenza alla sensazione.
Dai battiti al minuto al numero delle nuvole nel cielo.
Tutto era un esame critico.
Vittoria e sconfitta sono gemelle siamesi, se ne arriva una, arrivano entrambe.
Cercavo un appiglio, un appiglio per sminuire il mio successo, o il valore della mia prova. Segnavo dell’avversario mancante, o di quello che aveva reso sotto le attese, finendo con il derubricare la mia gara ad un valore sempre relativo.
Non lo facevo di certo apposta, ma non era nella vittoria la mia gratificazione.
Era altrove.

Il giorno in cui vinsi la prima Coppa del Mondo, una bella sfera di cristallo, me la dimenticai sul nastro trasportatore dell’aeroporto di Praga, e fu un addetto alla sicurezza a riportarmela tutto trafelato, mentre gli altri componenti della spedizione mi guardavano stralunati.
Era il mio primo anno da senior, e quella Coppa, persino ora, non saprei dire dove sia finita.
Ho passato tre lustri della mia vita a correre per mestiere, e in quei 15 anni è cambiato tutto, non soltanto per me.
È stato come scoprire che tutto quello che sapevo, e che sapevamo, della meccanica umana era, semplicemente, sbagliato.
Da Filippide al labirinto della mente: sono nato e sono cresciuto con l’ideale di arrivare ad una maratona come mia massima ambizione. Mano a mano, strada facendo, ho scoperto che c’erano gare che arrivavano ai 50 km di percorrenza.
Poi 80.
Poi 100.
Poi 150, poi 170, poi 300.
Poi 330.
E questa cosa mi faceva impazzire perché non riuscivo a decifrare lo sport dove stava andando, cioè il mio sport, che era quello di correre in montagna con dei dislivelli. Farlo per più giorni era completamente una pazzia.
Ho fatto troppo tardi alcuni passi, ho fatto troppo tardi alcuni salti. Mi sono concentrato troppo su una cosa in cui credevo, per esempio su distanze in cui credevo fortemente che fossero l’evoluzione, il futuro. Invece poi la storia ha dato ragione ad altri: le lunghe distanze, addirittura le lunghissime distanze, a cui io mi sono affacciato quando ormai avevo quasi 40 anni ed era finita l’epoca in cui avrei potuto performare.
Io non volevo arrivare a fare quello.
Diciamo che me l’ero imposto, come ideale, di non accettare questo tipo di sfida, di correre per 24 ore, ad esempio, perché mi sembrava stupido.
Poi in realtà ho scoperto, provandolo, che c’era qualche cosa di particolare, che mi dava un’emozione. Il fatto di essere dentro un’avventura, un’avventura con te stesso.
È il paradosso del corpo umano, che più gli chiedi e più ti da, in un equilibrio instabile dove dolore e piacere sono spesso la stessa cosa.
Con l’aumentare delle distanze, diventate sempre più assurde, sempre più incredibili, la corsa in montagna ha quasi smesso di essere uno sport ed è diventata pura scoperta.
Quando non riesci più a gestire le tue forze, perché non sai quantificare la strada da fare in relazione alle tue energie; quando continui a mettere in fila i passi solo per volere del cervello e non più del corpo, il confine tra pensiero e azione sparisce, e ti ritrovi in terre completamente inesplorate.
Sono passato dal gareggiare spalla a spalla con 4 o 5 avversari fino all’ultimo metro di una gara, a queste infinite cavalcate in solitaria, in cui gli altri sono soltanto fantasmi del passato persi nei loro boschi.
E resti tu, con tanti di quei chilometri da fare che la tua testa perde il controllo, perché non sa più tenerne il conto.
Le dita delle mani non ti bastano per ancorarti ad un numero e l’arrivo è soltanto un’idea, che potrebbe esistere, ma anche no, e per vedere se è vero, devi prima scoprire te stesso.
L’anima inizia a ragionare a blocchi, a soglie, e la stessa persona che dopo 10 ore di corsa sta bene ed è lucida, cinque minuti più tardi potrebbe anche non riuscire a connettere e farsi vincere dallo sconforto più nero.
Poi, un raggio di sole che filtra, una leggera brezza sul volto, ed ecco un nuovo istante di leggerezza, che rimette tutto in ordine e ti accompagna fino al prossimo confine.
Pensare a cose leggere aiuta ad abbassare i battiti del cuore e a far passare le ore, in un dialogo con la montagna e con la natura che diventa quasi parte del paesaggio, colonna sonora del viaggio quanto e più del vento, degli animali, e delle suole delle scarpe.
Non esiste un ricordo solo che possa descrivere appieno quel che mi da la montagna, e cosa mi abbiano lasciato i tanti chilometri consumati salendo e scendendo dai pendii del Mondo conosciuto.
È chiaro però che guardandomi indietro rivedo i puntini della mia vita, ed è semplice oggi unirli tutti con un tratto di penna.
Quanto sono stato fortunato a nascere qui, circondato da valli bellissime?
Quanto sono stato fortunato ad avere un padre che me ne ha trasmesso il reale valore?
Il paradigma si è ribaltato, e ora non vado più alla ricerca della prossima sfida, del prossimo limite, ma cerco di valorizzare l’unicità di quello che mi circonda per offrirlo agli altri, come mio padre fece con me.
Penso alla Livigno Sky Marathon, una gara in cui riporto tutto quello che ho appreso in ogni angolo del Pianeta, per poi applicarlo qui, in quella bellezza che posso chiamare casa.
Penso alle migliaia di persone che raggiungono le nostre valli, provenienti un po’ da ovunque, e che hanno la possibilità di esplorarne la natura, costruendo il proprio istante con essa.
È il bello della montagna.
Anche se qualcuno magari si arroga il diritto di dire come bisogna salirla e come bisogna rispettarla, io credo che il rispetto sia dato semplicemente da come tu la tratti. Da qual è il tuo rapporto intimo con lei.
Che sia una passeggiata oppure una corsa di un giorno intero, che sia l’impresa della tua vita o una gita in famiglia, la montagna ti premia sempre con una collezione di attimi che danno valore al momento.
Ancora mi chiedo quanto possano pesare una carezza, un bacio oppure un “bravo”.
Dopo quella prima volta, quella delle scarpe nuove, infatti non sono mai più andato a correre con mio padre.
Avevo 5 anni, e lui molti di più, quel giorno.
Lungo il tragitto un cane gli morse una gamba e fu così che la mia prima corsa in montagna fu anche la sua ultima corsa in montagna.
E anche se non è mai stato molto affettuoso, magari; anche se ho preso da lui certi lati del carattere, di una cosa sono certo per davvero e l’ho imparata grazie a lui: che più sali verso l’alto e più tutto si fa leggero.
MARCO DE GASPERI / CONTRIBUTOR