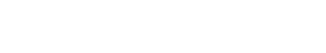"Sono al cancelletto.
Stringo gli attacchi.
Prendo in mano le maniglie.
E sento proprio che dalle mani, tutto il mio corpo si prolunga, fino alla tavola, e lo sento come un pezzo unico.
Cioè: i miei piedi si prolungano lungo la tavola, sento fino a 50 centimetri più avanti.
Sento tutto.
La muovo sotto di me e sento fin dove arriva.
Mi sento bene.
Non sento freddo, non sento caldo, ho il respiro basso, il diaframma basso.
Sguardo lucido, mi sistemo un po’ la maschera e sento proprio che sono centrata.
Sono dove devo essere, nel mio posto.
E quando mi sento così, faccio il tempo.
Faccio la gara giusta."
Fare la gara giusta non è mai questione di attimi e allo stesso tempo è sempre e solo una questione di attimi.
Dietro a quel cancelletto, con le mani che stringono forte le maniglie e che non vedi l’ora che ti proiettino, quasi ti lancino, a fondovalle, ci sono migliaia di ore.
Ore di lavoro, ore di allenamento. Ore di incertezza e di dubbio che ho trasformato con tenacia in convinzione e in sicurezza.
Ma, allo stesso tempo, solo il momento presente può dirmi quel che succederà per davvero.
Sono le sensazioni che provo prima della partenza, nei secondi immediatamente precedenti al count down, a determinare se, e come, la mia tavola e il mio corpo saranno una cosa sola.
Lo sport e la vita, o quantomeno il mio sport e la mia vita, sono costellati, da sempre, di decine di questi bivi.
Intersezioni del tempo, incroci della narrativa.
Lanci di una moneta che gira nel cielo e che potrebbe ricadere da un lato oppure dall’altro con la stessa, medesima, noncuranza.

Sono stata una bambina casinista, per esempio.
Ma ero anche molto affettuosa.
Mamma racconta di una figlia scalmanata, un maschiaccio che non accettava di perdere in nessun gioco e che tornava a casa sempre sporca di qualche cosa: che fosse terra, neve, erba oppure fango.
Eppure, ogni volta che mi accompagnava a piedi fino all’asilo, una volta entrata, correvo subito verso la finestra per poterla salutare con la mano e guardarla mentre percorreva a ritroso i 100, miseri, metri che avevamo appena camminato insieme.
Ero curiosa delle cose del mondo, ma del mondo avevo anche già scoperto la cosa che amassi più di tutte le altre: la mia casa e la mia famiglia.
Ancora oggi, che ho scelto un mestiere che mi fa viaggiare molto, vivo ogni partenza come un’avventura e contemporaneamente come un piccolo abbandono doloroso.

A dirla tutta, la passione che avevo è diventata il mestiere che ho scelto quasi a sorpresa, senza avvisarmi, senza prepararmi alla grandezza di tutto quello che mi avrebbe circondato.
In meno di due anni sono passata dalla Coppa Europa alla Coppa del Mondo e dalla Coppa del Mondo alla finale Olimpica, con quella dose di giusta incoscienza che solo chi è davvero sincero può avere.
È stato come un corso accelerato, complesso ed emozionante, che in brevissimo tempo mi ha insegnato più di quanto avessi imparato fino a lì.
Il bivio in cui avevo scelto lo snowboard era arrivato ben prima del biennio che ha preceduto Sochi 2014, e quella sì che fu una scelta molto facile.
Di qua lo sport di squadra e di là quello individuale.
Ho scelto di esser sola.
Ho scelto di esserne la protagonista assoluta, perché a vincere, oppure a perdere, volevo essere io.
È bello condividerlo, certo, e forse sarebbe anche stato divertente scoprire com’è vincere in uno sport di squadra.
Magari mi sarebbe piaciuto.
Ma per come sono fatta io, che sono un po’ egocentrica, mi piace così. Mi piace molto.

Poi, crescendo, diciamo a metà strada tra l’asilo e Sochi, mi sono accorta che questa passione mi rendeva diversa dagli altri. Nè migliore né peggiore, soltanto diversa.
C’era un’energia unica in me.
Io, che amavo fare cose che gli altri non amavano fare e che non sempre sono riuscita a viverla con la leggerezza che avrei voluto.
Era difficile accettarmi per quello che sono.
Un giorno ci riuscivo e in quello dopo invece no.
Finché non ho vinto il mio primo campionato italiano, durante la terza media, ed ho iniziato ad annusare l’idea che tutto questo potesse essere un dono e non una maledizione.
Ho iniziato a credere che il mio modo di essere potesse darmi qualcosa in più, che la strada che avevo intrapreso fosse quella giusta per me.
Tanti anni dopo ci sono ancora cose del mio carattere che sopporto a fatica, o che vorrei smussare, o addirittura che vorrei cambiare.
Ma oggi so che se sono arrivata qui lo devo anche all’ostinata forza dei miei difetti, e alla loro capacità di modellare il mio carattere.
Come la cocciutaggine, che quando fai qualcosa di grande, come per magia, per tutti gli altri diventa resilienza.
Io ho sempre saputo che avrei fatto qualcosa di grande.
Anche quando non sapevo ancora cosa, ne ero comunque sicura. Praticamente certa.
E così, quando sono arrivata all’Olimpiade, per quanto spaesata, mi sentivo pronta a mantenere la parola data a me stessa.
A quel bivio però ho preso la strada più lunga.
Non dico quella sbagliata, ma la più lunga di sicuro sì.
.jpg?width=3024&name=Pentaphoto_135914%20(2).jpg)
Al cancelletto di ogni run, a Sochi, mi sentivo le gambe come due budini, e pronti-via mi ritrovavo subito in fondo al gruppo.
Poi il contorno spariva, io tornavo io, e così recuperavo una posizione alla volta, fino ad assicurarmi il passaggio al turno successivo.
È andata così in tutte, tranne che in finale.
Perché in finale, quando da quarta ero diventata terza, proprio nel momento in cui ho intravisto una medaglia, sono caduta e mi sono rotta il crociato.
Sarei potuta restare in scia, aspettare la fine della curva e poi superare, ma avevo 18 anni e non sapevo davvero cosa stessi facendo.
Ho pianto dopo la gara.
Eppure è stato anche come togliermi un peso di dosso, per ritornare alla vita di prima, quella più semplice e piccola; quella in cui l’obiettivo reale non era una medaglia olimpica, ma prendere il diploma e la patente nello stesso anno.

Non ho mai dubitato che sarei tornata, né tantomeno ho dubitato che sarei diventata più forte di prima.
Solo c’erano tante cose ancora in via di guarigione. Tante, oltre al ginocchio.
E ci sono voluti quattro anni per costruire quel qualcosa che mi permettesse di raggiungere il mio obiettivo più grande.
Potrei raccontare di Pyeongchang 2018 come di una lunga rivincita, come della chiusura di un cerchio magico, che raccoglie nella stessa pagina il dolore e la gioia, la frenesia e la celebrazione.
Oppure potrei farlo per come è andata veramente, perché dentro a un quadriennio c’è molto, moltissimo, e non si può riassumere tutto nel titolo maiuscolo di un giornale.
Sulla carta, quella coreana era la mia Olimpiade.
Un oro atteso.
Un peso grande, che con i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti ho partecipato ad alimentare in prima persona. Un’escalation emotiva che mi ha portato al cancelletto della finale con un misto di carica e di paura, perché quella non mi abbandona mai.
Paura di aver sbagliato qualcosa, di essere troppo agitata o troppo poco agitata.
La paura arriva prima di ogni gara e prima di ogni gara io mi obbligo ad affrontarla, non resta mai inespressa, o latente.
Siamo io e lei, e regoliamo i nostri conti da sole.
"Ovvio che quando tutti si aspettano che tu vinca diventa ancora più difficile vincere.
Ma in realtà dipende da te e da come riesci mentalmente, se non a estraniarti, almeno a evitare di pensare a quello che pensano gli altri di te.
Quello che si aspettano gli altri da te.
Se io riesco a concentrarmi su di me, sui miei punti di forza, sulle mie sensazioni, per evitare di pensare che da casa mi stanno guardando, che i miei allenatori si aspettano che vada forte, che i miei sponsor si aspettano che vada forte…se riesco ad estraniarmi da queste cose, allora sì che riesco ad andar forte per davvero."
Ma non basta.
Devo anche sentire i segni del destino, quasi come un allineamento dei pianeti che appare all’improvviso e che certifica l’assoluta importanza del momento che sto vivendo.
Casa mia, una volta era una dogana, un bivio, e non è raro che dalla terra dell’orto saltino fuori ogni tanto degli oggetti che i viandanti erano costretti ad abbandonare per strada, piuttosto che cederli al doganiere di turno.
A pochi mesi dalle Olimpiadi del 2018, proprio mentre mi dedicavo al giardinaggio, ho visto luccicare qualcosa che assomigliava molto al tappo arrugginito di una birra dell’epoca.
E invece era un anello, perfettamente conservato e tempestato di pietre verdi, bianche e rosse.
Incastonate perfettamente: non ne mancava neppure una.
"Ho deciso che quell’anello me lo sarei portato in Korea e che se avessi vinto lo avrei lasciato lì.
E così ho fatto.
Ho gareggiato con l’anello, infatti nelle foto sul podio mentre mordo la medaglia si vede.
Finita la premiazione ho chiesto al fisioterapista, Marco, e al medico della squadra, Gabri, che era lo stesso che mi aveva operato al ginocchio quattro anni prima, di accompagnarmi.
Abbiamo scavalcato le reti e siamo entrati.
Siamo andati proprio all’arrivo della pista di snowboard cross, ho fatto un buco e l‘ho seppellito lì."
Quella vittoria poteva cambiare tutto oppure non cambiare niente, e nel mio caso, forse, ha fatto un po’ di entrambe le cose.
Non sono ancora capace di dirmi brava, anche se dovrei imparare a farlo, perché il percorso è difficile e non giudicarsi con troppa durezza è uno dei segreti del successo.
Allo stesso tempo, però, ho vinto un oro olimpico e me lo dimentico spesso, perché voglio vedere quello che c’è dopo, e avere ancora fame è, anche quello, uno dei segreti del successo.
Ho compreso che nonostante fatichi tutto l’anno, e tutti gli anni, ti ricorderanno solo per i successi e le medaglie, come se negli altri 364 giorni il tuo lavoro valesse qualcosa meno.
Ma ho anche capito che mi piace raccontarmi per la persona che sono, perché alla fine siamo esseri umani, prima che atleti, e sono le nostre passioni, e le paure, ad avvicinarci veramente alle persone.
Ho capito che nello sport il più grande bivio è quello della motivazione, e quella o ce l’hai o non ce l’hai.
La costruisci, giorno dopo giorno, perché non va in vacanza e non riposa, e nel momento esatto in cui la perdi inizi una discesa a cui è impossibile mettere dei freni.
Per un istante mi sono sentita vuota, quasi persa.
Avevo fatto tutto per vincere l’oro olimpico.
“E adesso?” mi sono detta.
Poi ho incontrato Antonio Rossi, che di ori olimpici ne ha vinti 3 e che mi ha raccontato della sua carriera, e così ho cominciato a rimettere tutto nella giusta prospettiva.

Per arrivare a 3 ori olimpici la strada è ancora lunga, ma sono più determinata che mai, anche, se non soprattutto, adesso, che senza gare mi sento come un leone in gabbia.
Prima ci sarà Pechino 2022, certo, ma anche se non dovrei, non posso non pensare già a quello che sarà per il nostro Paese l’Olimpiade del 2026.
Guardo la montagna da qui, guardo il bosco dove sorgerà la pista, la mia pista.
"Un po’ la visualizzo.
Però io vado molto step by step, anche perché sono già ansiosa di mio.
Devo affrontare una cosa alla volta, di anno in anno.
Solo così arrivo al 2026.
Se pensassi di arrivare al 2026, pensando solo al 2026, e non a tutto quello che c’è prima, non ci arriverei.
Però me lo immagino già un po’ come sarà.
Secondo me a livello visivo non cambierà tantissimo, nel senso che non si faranno più i grandi eventi come li facevano prima, che deturpavano tutto, costruivano, disboscavano.
Sarà molto diverso, sarà molto più a misura della natura e dell’uomo."
Sarà una festa, ci saranno i tifosi e le persone a me care, e penserò a tutti loro quando sarò al cancelletto pronta per partire.
Vorrò farli divertire, perché saperli lì mi da una scossa di energia.
Avrò fatto tutto bene, avvicinandomi alla gara, sarò in forma e sentirò esplodere dentro la mia solita voglia di mangiare la pista a bocconi grossi.
Poi tutto sparirà di colpo, la gente, le pressioni, Livigno a fondovalle.
E allora saremo solo io, la mia tavola e la mia paura.
Ci guarderemo in faccia, senza esclusione di colpi.
Infine sentirò la tavola diventare un pezzetto di me.
MICHELA MOIOLI / CONTRIBUTOR