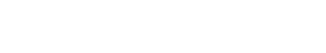Il primo volo fu un tranquillo Milano - Roma.
Tratta quotidiana.
Un volo domestico, pieno di uomini in carriera con le ventiquattrore e di famiglie in partenza per le classiche vacanze romane.
Fu il secondo volo, Roma - Sofia, ad essere decisamente più movimentato.
Ci imbarcarono su un aereo militare piuttosto sgangherato e traballante, scortati dai militari sovietici, che ci osservavano con un misto di ammirato stupore e di rigida disapprovazione.
Quelli erano gli anni Settanta, e il Mondo intero era così ingessato e diviso, che a raccontarlo oggi i più giovani farebbero fatica a crederlo possibile.
C’era la cortina di ferro, la Germania era divisa a metà, anche se non era esattamente metà, e l’Europa intera sembrava come la mappa di una partita a Risiko in costante fermento.

Noi non eravamo né politici né attori.
Non eravamo neppure marinai o astronauti.
Ma eravamo, a modo nostro, dei pionieri.
Atterrammo e ci accompagnarono subito in una località poco distante dalla capitale bulgara.
Eravamo un gruppo eterogeneo, ognuno proveniente da un angolo diverso del pianeta, ma tutti uniti dalla stesso, profondissimo, desiderio di libertà.
Il nostro non era solo uno sport.
Era un messaggio.
Questi eventi ci permettevano di portare le nostre idee e la nostra creatività ad ogni latitudine, oltre a riempirci un po’ le tasche, visto che il circuito dell’hot dog, da solo, non bastava.
L’organizzazione sovietica fu puntuale, precisa.
Centinaia di militari in divisa si muovevano per la pista, come tante formiche operose.
Esecutori non pensanti, che con le nostre direttive costruirono i trampolini, i pendii artificiali e le gobbe.
Un vero e proprio palcoscenico per la nostra esibizione del giorno dopo.
Andammo a letto ripassando le sequenze dei salti, la scaletta del nostro show; quasi pregustando gli oh di meraviglia che sempre accoglievano le nostre acrobazie sugli sci.

Il mattino seguente, quando ci affacciammo dalla finestra, la pista era sparita, completamente sommersa da un mare di puntini neri, tutti schiacciati uno fianco all’altro, in paziente e diligente attesa di ciò per cui erano venuti fin lì.
Le teste dei presenti si muovevano come un corpo solo, in attesa del colore e della follia che il vento dell’ovest avrebbe portato sulla loro neve.
Una deviazione dalla narrativa.
La prova provata che esistesse un altro modo di pensare.
Erano così tanti che, senza volerlo, avevano distrutto il trampolino.
Lo ricostruimmo.
Poi offrimmo lo spettacolo della loro vita, acclamati dalle grida e dagli applausi, con il nostro stile e la nostra lucida follia.
A migliaia di chilometri da casa, come sempre accadeva a quel tempo, e ancora più lontano filosoficamente, noi portavamo un modo diverso di fare le cose.
Come una ventata di aria fresca, che apre la mente più che i polmoni, e che serve per trovare la propria strada per davvero.
Una lezione che ho imparato fin da piccolo.
Io ho avuto la fortuna che i miei genitori e la mia famiglia vivevano in un albergo, che hanno costruito nei primi del ‘900.
E quindi abbiamo avuto la fortuna di avere sempre gente per casa.
Con i turisti avevi sempre un altro tipo di rapporto.
Noi ragazzi ci interfacciavamo con i figli dei turisti, si faceva veramente cagnara, ed era quella la leva, il grimaldello, che ti introduceva in un mondo che non era propriamente quello di Livigno, perché così facendo avevi contatti con gente che faceva tutto un altro tipo di vita.
La Livigno del dopoguerra era come un paradiso terrestre, nascosto alla vista dei più.
Un angolo di montagna, quasi inaccessibile eppure bellissimo, capace di esercitare un fascino unico sul cittadino metropolitano, costretto in spazi angusti dall’urbanizzazione della Terra, anche per la sacralità che emanava il rapporto tra l’uomo e la natura circostante.
Si viveva principalmente di agricoltura e fino all’inizio degli anni ’60 non ci fu traccia del grande turismo che oggi rappresenta il cuore dell’economia locale.
Non tutti potevano permettersi gli sci, per questo ricordo con dolcezza il momento in cui mi regalarono il mio primo paio.
Mio padre aveva battuto un piccolo anello per il fondo davanti a casa, e non appena sono stato in grado di pattinare a lisca di pesce ho iniziato ad usarli anche per andare a scuola la mattina.
Era poco più di un chilometro, ma era pur sempre bellissimo.
Lo sci organizzato arrivò dopo.
Lo portarono le brigate alpine, che organizzavano delle piccole garette, in giro per le valli, alla ricerca dei talenti locali da portare poi sul palcoscenico regionale e nazionale.
Arrivavano con i cronometri, con i pali, e montavano tutto.
Sembravano astronauti durante l’allunaggio.
E noi li guardavamo con lo stesso stupore, mentre si muovevano sul manto bianco come non avevamo mai visto fare prima.
Quando vinsi il pass per le finali nazionali uscii per la prima volta dalla mia valle.
Avevo 8, 9 anni e mai avrei immaginato che lo avrei fatto così tante volte, dopo di quella.
La scuola, a parte il tragitto per andarci, non faceva per me, in classe ero un disperato, e i miei decisero di spedirmi lontano per le superiori, in collegio, salvo poi venire a recuperarmi tutti gli anni in prossimità del trofeo delle contrade perché la mia abilità sugli sci era utile a stabilire la supremazia cittadina.
Il trofeo si organizzava ogni inverno, e perderlo significava assicurarsi un anno di sberleffi e prese in giro da parte dell’altra metà di Livigno.
Quindi meglio prenderlo sul serio.
Poi, crescendo, cominciai anche a fare qualche gara vera. Quelli erano gli anni del boom per lo sci alpino, gli anni della valanga azzurra, e io non mancai di fare qualche discreto risultato.
Ma quelle erano anche le stagioni del ’68, inteso come momento di rottura, movimento globale di rifiuto della tradizione, che scardina le rigidità dei benpensanti e dei paurosi.
L’immagine dello sciatore era presto diventata quella dello sciatore in famiglia, come in un quadro appeso alla parete dove tutto è al proprio posto, esattamente dove dovrebbe essere.
Ma la neve è più di questo.
La neve è estasi ed estetica. È la ricerca del limite e la sua stessa ridefinizione.
Nel momento esatto in cui l’essere sciatore si era cristallizzato nell’immagine ingessata di un percorso già battuto e uguale per tutti, ecco che lo spirito dell’epoca esplose come un forte grido di ribellione.
Fu l’epoca del fuoripista, della ricerca del pendio più ripido e della neve più alta.
Espressione di una libertà da guadagnare per noi e anche per tutti gli altri.
Fu l’epoca dell’hot dog.
Quello dell’hot dog era un circuito parallelo, che arrivava dall’America, proprio come gli astronauti dell’allunaggio, e che portava con sé tutto il fascino della scoperta, una rivoluzione dei modi e della cultura.
C’erano tre discipline uniche, nuove, pazze e adrenaliniche, e il risultato finale della competizione dipendeva dalla loro combinazione.
Anche se poi, il risultato finale, era la cosa meno importante in assoluto.
La discesa tra le gobbe, le serie di salti e il balletto.
Si respirava l’elettricità del cambiamento; prendevamo qualcosa di antico, di classico, e ne facevamo un uso diverso, pericoloso persino, sicuramente ipnotico.
Si valutavano lo stile, la complessità delle figure, anche l’emozione suscitata nel pubblico.
Era un grande spettacolo, in cui tra idea e azione non c’era più alcun filtro.
Solo la fantasia, il coraggio, il desiderio di esprimersi e di far primeggiare il proprio animo libero.

Giravamo per le montagne di tutto il mondo, per portare il nostro messaggio, l’espressione di appartenenza a un ambiente inclusivo, in cui tutti erano ben accetti.
Un modo di vivere la montagna in cui la sola persona straniera era la paura.
La paura è facile da riconoscere, perché nella stanza é colei che parla a voce più alta degli altri.
Ma noi le dicevamo: no.
Semplicemente no.
Sempre alla ricerca della prossima figura, del salto più impressionante, della combinazione più pazza e pericolosa.
I salti mortali, i doppi, i tripli, gli axel, la spaccata singola, che doveva diventare per forza doppia, nella tappa successiva.
Far parlare di noi era il nostro obiettivo, e l’obiettivo ci dava la forza.
Fatico a rapportare quello stesso spirito alla vita che i giovani possono fare oggi.
Eppure si deve fare.
Si deve.
"Veramente, i ragazzi devono lottare per quel qualcosa.
Devono trovare una motivazione nel perseguire le proprie passioni e arrivare a realizzare i propri sogni.
Questi erano i nostri sogni.
E i sogni vanno coltivati."
Non avevamo paura di interpretare i tempi che vivevamo e altrettanto devono fare i protagonisti del contemporaneo, con le loro ribellioni alle ortodossie di oggi.
Non di ieri.
La cortina di ferro non c’è più e non ci sono folle oceaniche ad aspettarci a fondo valle per poter finalmente ammirare qualcosa di diverso, ma questo non toglie che lo spirito di allora alberga ancora in noi.
Così come il seme della libertà.
L’hot dog è diventato il freestyle ed è finito dentro il programma olimpico, perché solo i soldi a 5 Cerchi potevano garantirgli la longevità a cui molti suoi protagonisti ambivano.
Non fu affatto indolore.
Perse un po’ della sua identità inconfondibile e molti di noi lasciarono il circuito, alla ricerca di nuove battaglie da combattere.
Ma quello che abbiamo costruito, il nostro movimento, è lì da vedere, è lì da toccare ed è lì per ispirare le nuove generazioni.
Ci apparterrà per sempre, perché quello delle emozioni è l’unico business in cui il tuo prodotto, dopo essere stato venduto, continua ad appartenerti.

E allora aspetto le Olimpiadi nella mia Livigno, che durante questi anni in cui tutto è cambiato, ha mantenuto intatta la sacralità della natura e la sua anima indomita, che vuole cavalcare la neve, come una fedele compagna, senza piegarla al proprio volere.
E aspetto le Olimpiadi con la stessa eccitazione con cui mi buttavo dal trampolino.
Che poi è la stessa che provavo da bambino, nei giorni delle nostre primissime discese, perché puoi anche girare il mondo, ma alla fine si torna sempre alle origini.
"Facevano il piazzale del negozio della via Ostaria, dove adesso è la Piazza Mottini, buttavano la neve contro la chiesetta e creavano una discesa con il tetto della chiesa, fino ad arrivare giù.
Sul piazzale.
Era il regalo che ci facevano quando c’erano gli inverni belli nevosi.
Loro mettevano tutta la neve lì e noi potevamo sciare poi dal tetto della chiesa fino a giù.
Completamente liberi."
DAMIANO BORMOLINI / CONTRIBUTOR