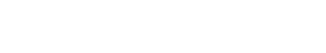La mia storia è una storia come tante.
Di quelle che ce ne sono migliaia, nel mondo dello sport.
Non ha davvero nulla di speciale, ed è proprio nella sua normalità che diventa importante. A partire da quell’inizio, così banale, che il passare del tempo e i risultati hanno trasformato poi nella mano del destino. Quantomeno ai miei occhi.
Un bambino che soffre d’asma, a cui consigliano di fare un po’ di sci di fondo per allenare i polmoni. Un bambino che vive a Livigno, dove lo sci di fondo arriva fino a bussarti alla porta di casa.
Semplice, che più semplice non si può.
La discesa l’avevo provata qualche anno prima, ma non mi era piaciuta per niente, e quell’imposizione del medico a fare attività mi aveva colto un po’ alla sprovvista.
Poi, come spesso accade, quando ho cominciato ad allenarmi davvero mi sono accorto di quanto fosse bello lo sport, di quanto mi piacesse stare insieme agli altri e di quanto fosse divertente vincere qualcosa.
Garetta dopo garetta, arrivare al traguardo per primo da una sensazione di benessere: la chiusura di un cerchio perfetto, che cancella tutti i passi falsi di un percorso iniziato nella solitudine della fatica e del desiderio.
E non importa il livello e non importa il momento: arrivare in fondo è sempre un regalo.

Ecco, la mia carriera, nel suo racconto, potrebbe anche finire qua.
Ci sarebbe poco altro da aggiungere.
Ho provato il fucile, mi sono accorto che era ancora più divertente dello sci di fondo e così sono passato al biathlon.
Ho fatto le nazionali giovanili, emozionandomi come tutti gli altri nel vestire l’azzurro per la prima volta.
Sono diventato un professionista, scoprendo che correre per mestiere è più complicato di quanto immaginassi.
E infine ho inseguito i migliori del circuito per tutta la vita, in un tira e molla senza fine, dove felicità e tristezza convivono sempre, pur parlando due lingue diverse.
Vent’anni di fila, a fare sempre la stessa cosa, in una routine pre-impostata che ha iniziato col definirmi, col dire chi sono, anche se io, dentro, sapevo di avere anche altro.
Diventi “l’atleta”.
E va bene così.
Insieme al tuo nome, oltre il tuo nome: è come se un pezzo della comunità intera si staccasse, salisse su un' astronave (che molto più spesso è un pulmino) e iniziasse a trottare per il Mondo, con lo stendardo di casa in tasca, da provare a infilare sui cucuzzoli delle montagne altrui.
E quel pezzetto sei tu, che rappresenti tutti gli altri.
“Al nos bocia”, che tu lo voglia oppure no.
Ventiquattro ore al giorno, in gara oppure no.
Sette giorni su sette.

Forse per questo ho sempre sentito le farfalle nello stomaco quando dovevo correre in casa, quando vedevo delle facce conosciute lungo tutto il percorso, impegnate ad incitarmi e a farmi sentire il loro supporto.
Non ho fatto tante tappe di Coppa del Mondo, e in quelle poche che ho fatto, nel mio cuore e nelle mie budella, ventimila cristiani urlanti non facevano neppure lontanamente il rumore della gente di Livigno, assiepata sul marciapiede per la Gara delle Contrade.
O per la Stralivigno.
Nessuno è profeta in Patria, perché tutti hanno avuto modo di vederti inciampare, almeno una volta, e quell’immagine rimane. Eppure è vero anche, che nessuno è mai solo, in Patria, e che il vialetto di casa è l’unico posto dove sei sicuro di trovare sempre la mano di qualcuno pronta a tirarti in piedi, quando hai il culo per terra.
Tra dare e avere c’è un equilibrio sottile soltanto per chi guarda con gli occhi.

Come atleta, pur senza smettere mai di sentirmi astronauta in missione, ho vissuto molti più giorni grami, che giorni di gloria. Le soddisfazioni vere, quelle del risultato raggiunto, le posso contare forse sulle dita di un paio di mani, mentre ai risvegli di fatica, di incazzatura e di gambe dure ho smesso di pensare tanto tempo fa.
Perché sono troppi da tenere a mente.
Due decenni fatti a immagine e somiglianza del mio carattere: sincero nel fare le cose, e felice di farle nel buio, per il loro valore profondo.
Perché è bello farle e non perché c’era qualcuno a guardarmi.
Quando ho deciso di smettere mi sono sentito perso.
Confuso e spaesato: l’atleta che vive in me era già in pace con se stesso, cosciente di essere arrivato esattamente dove sarebbe potuto arrivare.
Ma l’uomo no.
Quello aveva, e ha tuttora, più di qualche paura.

Così, per trovare il mio nuovo posto nell'universo, ho pensato di aver bisogno di un rito di passaggio. Come quei giovani dei romanzi per bambini, che devono trascorrere una notte da soli nel bosco e uccidere il lupo, entrando ragazzi e uscendo adulti, per capire davvero se quel che hanno dentro sarà sufficiente ad affrontare la vita.
E la mia traversata del bosco sarà Icon, il triathlon più estremo al Mondo.
Ricordo che il mattino della prima edizione pioveva ed io sono uscito di casa presto per andare a fare degli esami medici dall’altra parte del paese. E mentre passavo davanti al lago, nella penombra di lingue di fuoco, guardavo gli atleti uscire dalle onde, infagottati dentro le loro mute, piegati in due dal freddo e dall’acqua.
Un teatro delle ombre, silenzioso e lontano: distante dalle mie preoccupazioni almeno quanto io lo ero dalle loro.
E anche se le gambe si muovevano a rilento, come se dovessero imparare a camminare di nuovo, nulla riusciva a fermali, in quell’incedere lento e inesorabile di chi sta facendo quel che gli piace.
Ho visto la scintilla, in loro.
Professionisti, alcuni.
Certo.
Ma architetti, idraulici, studenti e commercianti, tutti gli altri.
Persone che prendono i brandelli del proprio tempo libero e lo dedicano a sfidare se stessi, preparando la gara più dura che c’è.
Ho pensato a come la mia quotidianità ruotasse solo intorno allo sport professionistico, quello che non lascia nulla al caso, e a come fosse progettata apposta per tirare fuori sempre il meglio di me, senza lasciare spazio all’immaginazione.
Poi ho pensato a tutte le pause pranzo, agli allenamenti prima dell’alba, alle ferie sacrificate, ai chilometri fatti a proprie spese che quella massa di piccoli eroi senza nome doveva aver accumulato anche solo per iniziare a pensare di poter affrontare Icon.
E mi si è scaldato il cuore.
Così, nel momento più difficile tra tutti, quello in cui devo trovare il modo per riempire uno spazio che per tanto tempo ha conosciuto soltanto il biathlon, mi sono ritrovato a desiderare di essere esattamente come loro.
La vera anima dello sport è sporca, ed è umida.
È fatta di paura quotidiana, di acido lattico e di maledizioni, gridate ai sette venti quando ti accorgi di non essere neppure a metà del tuo programma.
L’allenamento non è altro che il reiterarsi infinito di una volontà personale, inalienabile e non trasferibile, come gli assegni: vasca dopo vasca, passo dopo passo, è l’espressione di un’idea di cui non si vuole ammettere il fallimento
Ma quella dello sport è anche un’anima fatta di libero arbitrio, fatta di scelta.
Un’anima che appartiene a chi decide di appartenergli e di fare di lei uno stile di vita.
Guarderemo sempre i grandi campioni, e spereremo nell’ombra che i nostri figli provino ad imitarli, nella speranza che scatti qualcosa dentro di loro.
Qualcosa che vale il viaggio e che nessuno mai potrà più fargli dimenticare.
Lo sport non è per tutti.
Lo sport è di tutti.
Ed io ne ho capito il valore appena ho smesso di farlo per mestiere.
È un pezzo del mio DNA, esattamente come lo è la comunità in cui vivo, e ora sento di dover attraversare il bosco a fari spenti, prima di poterlo a vivere a polmoni aperti.
Spogliato della divisa di una vita, entro da un lato del tunnel e spero di uscirne dall’altro lato: uguale a me stesso, stanco da buttare via, leggero, e felice di aver ripreso contatto con ciò che davvero mi ha fatto innamorare dello sport.
L’esperienza.